(Sesto Potere) – Cervia – 14 agosto – Ieri sera, presso il MarePineta Resort di Milano Marittima, nell’ambito della manifestazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”, è sta presentata in anteprima nazionale la mostra 2026 organizzata al Museo Civico San Domenico dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì.
La nuova esposizione d’arte sarà dedicata al: ‘Barocco. Il gran teatro delle idee’, e andrà in scena dal 21 febbraio al 28 giugno.
Sono intervenuti il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il vice sindaco di Cervia Gianni Grandu, il presidente di Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini e il presidente dell’associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” Cesare Brusi.
Ha illustrato i contenuti della mostra il vice presidente della Fondazione e direttore generale delle grandi mostre ai Musei San Domenico Gianfranco Brunelli (nelle foto).

Attesi capolavori provenienti da musei di tutto il mondo tra i quali: il Musée Rodin e il Musée du Louvre di Parigi, i Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, il Musée du Berry di Bourges, il Museo de Arte de Ponce, e il Germanisches Nationalmuseum di Norimberga.
Opere inestimabili in mostra di grandi artisti come per esempio: Pieter Paul Rubens, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, il Guercino, Michelangelo, Artemisia Gentileschi, Diego Velázquez, Rubens, Giorgio de Chirico e Lucio Fontana.
“Il Seicento fu Roma. La città dei papi, erede della città dei cesari. Tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, Roma richiama i migliori talenti artistici, le élites intellettuali, gli spiriti eccelsi dei nuovi ordini religiosi, i gesuiti, i cappuccini, i teatini, gli oratoriani, nel clima della riorganizzazione politica e religiosa promossa dalla Riforma cattolica e dalla Controriforma dopo il Concilio di Trento. L’arte è al centro della riconquista cattolica. Ne è il linguaggio espressivo. E quel che verrà in maniera dispregiativa chiamato Barocco ne è la cifra simbolica, la dimensione culturale del secolo”: ricorda Gianfranco Brunelli.
“Le idee elaborate e sperimentate in provincia, siano esse le scuole artistiche della penisola o le esperienze europee, trovano a Roma – nel confronto con l’antichità classico-ellenistica e col lungo Rinascimento – il loro orizzonte rappresentativo. Roma è il grande cantiere della storia che offre nel confronto delle idee le occasioni professionali per l’affermazione degli artisti e genera lo sviluppo delle arti. E sarà soprattutto l’architettura e il disegno urbanistico a imporre una immagine originale e moderna alla città. Già ai papi del Rinascimento era parso chiaro che la magnificenza di un sovrano si manifestasse dall’imponenza della sua capitale. La sistemazione di strade, piazza, così come quella di chiese e palazzi sarà il linguaggio comunicativo. La ricerca dell’effetto scenico, teatrale, sottende a tutti questi interventi”: continua il vice presidente della Fondazione e direttore generale delle grandi mostre ai Musei San Domenico.
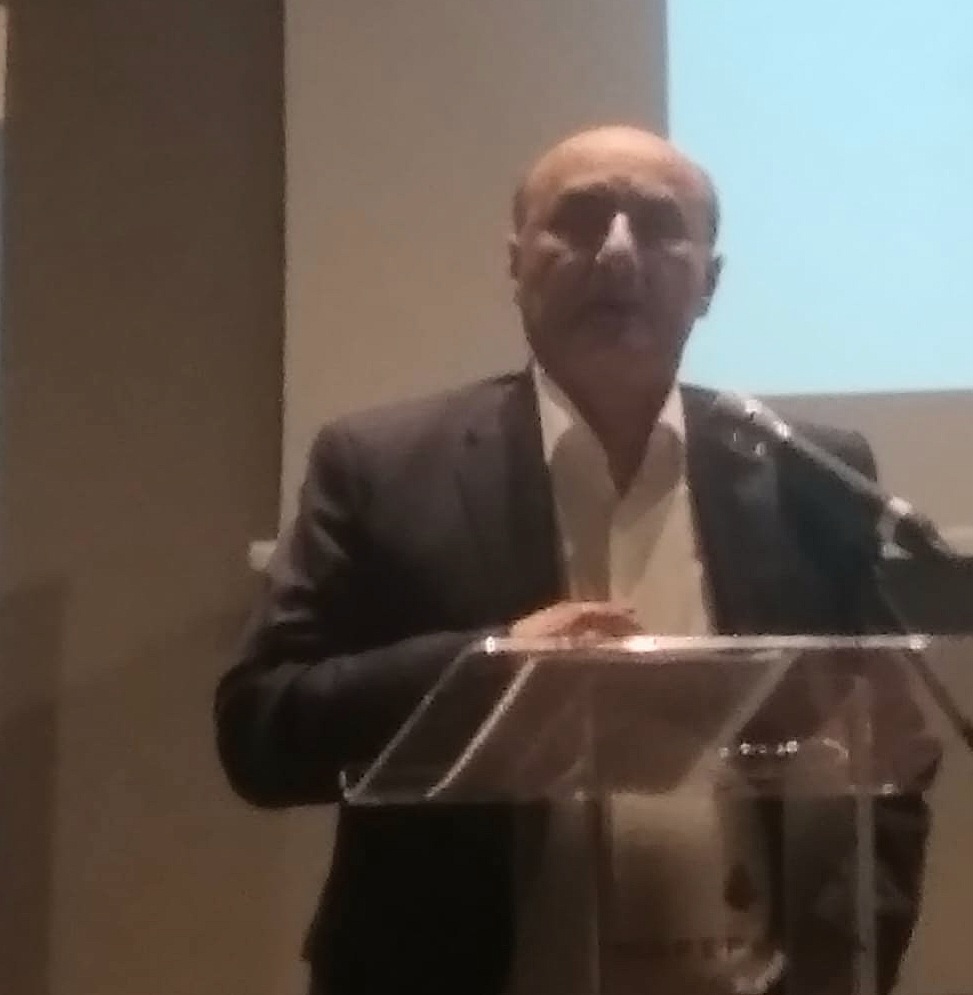
“Dalla provincia, seguendo la trafila delle committenze e i cammini degli ordini religiosi, giungono a Roma i talenti migliori. Arrivano dalla Svizzera Carlo Maderno, il ticinese Borromini e il lombardo Michelangelo Merisi, le cui vicende personali hanno più di un punto in comune, tra l’eccesso realistico e l’eccesso fantastico. Dalle legazioni pontificie arrivano i bolognesi Annibale Carracci e Guido Reni e poi al seguito, a ondate successive: Algardi, Guercino, Lanfranco, Domenichino, Albani, Sacchi, Maratta. Arrivano i toscani Francesco Mochi, Pietro Berrettini da Cortona. Da Napoli, dove si era trasferito, arriva il toscano Pietro Bernini che cederà al figlio Gian Lorenzo il podio, Luca Giordano e il letterato Salvator Rosa. Da Genova, Giovan Battista Gaulli; e dall’Europa, com’è noto, Rubens, Antoon van Dyck, Velázquez, Nicolas Poussin, Claude Lorrain”: elenca Gianfranco Brunelli.
“Papi, principi e cardinali, appartenenti alle grandi famiglie (come i Borghese, i Barberini, i Chigi, i Ludovisi, i Pamphilj), sono i promotori di un grande rinnovamento urbanistico e architettonico. Nonché di un nuovo universo figurativo a proseguire, rifondandola, la grande tradizione artistica italiana. Soprattutto con Urbano VIII Barberini, e poi con Alessandro VII Chigi il Barocco diventa il linguaggio figurativo del papato: un’arte religiosa che si fa programmaticamente arte pubblica è stato detto di Stato. E Roma è l’occasione e la vetrina. Accoglie tutte le tendenze, anche le più contrastanti.”: illustra il direttore generale delle grandi mostre ai Musei San Domenico di Forlì.
E poi Brunelli entra nel dettaglio: “Tutto si compie sotto il segno del Barocco. Irriducibile Barocco. Politica e religione sono i due fuochi dell’ellisse del Barocco. Cultura figurativa, idea estetica, linguaggio poetico si intrecciano narrativamente. Inafferrabile e contraddittorio Barocco. Visione sospesa della realtà tra vero e meraviglia, reale e immaginario, inquietudine e trascendenza, carnale e mistico (si pensi alla sospensione tra il nulla del puro svuotamento e lo spasmo amoroso verso Cristo di Santa Teresa d’Avila o San Juan de la Cruz, o di Santa Maria Maddalena de Pazzi), regola e movimento, nascondimento e teatralità: il Barocco appare eclettico e sincretico. Centro di gravità della disproporzione tra due infiniti: il particolare e l’universale, la terra e il cielo, l’umano e il divino. Barocco è quel sottile e tormentato dissidio tra “l’uscir di regola” delle linee borrominiane e il recupero allegorico delle nuove armonie ritmiche berniniane. Barocca è l’antitesi tra la fantasia che segue la “regola” e si sviluppa in forme naturalistiche o antropomorfe, come nell’apollo e Dafne di Bernini e la fantasia che ripudia la “regola” in forma bizzarra e furibonda, alternando linee concave a linee convesse, come nel San Carlino alla quattro fontane di Borromini. Barocchi sono i paesaggi idealizzati di Domenichino e la mitologia narrativa di Poussin, le cupole affrescate dal Lanfranco (memore di Correggio), la silenziosa commozione “romantica” e coloristica di Guercino. Barocco è il berniniano colonnato di San Pietro che abbraccia il mondo come cristianità e il naufragio dei sensi dell’estasi di Santa Teresa in Santa Maria della Vittoria e della beata Ludovica Albertoni di San Francesco a Ripa. Barocco è il campanile di Sant’Ivo alla Sapienza di Borromini, con quell’andamento tortile, frutto di una tecnica febbrile e di un furore ispirato che non sai dire se richiami ancora il Gotico o anticipi l’Art Nouveau. Barocche sono le fontane. Barocchi sono i cieli centrifughi e affollati di Pietro da Cortona, di Giovan Battista Gaulli e del gesuita Andrea Pozzo, che sanno già di Keplero e Galileo. Molti sono gli artisti eccelsi che scelgono Roma per i loro linguaggi. Boracco è Rubens a Santa Maria in Vallicella che apprende da Annibale Carracci come far sintesi tra Tiziano e Correggio. Barocco è già la deposizione di Caravaggio dei Vaticani cui lo stesso Rubens farà una sua versione, oggi a Ottawa”.
“Poi da Roma gli artisti troveranno le altre corti italiane e l’Europa. Artisti che erano stati più volte a Roma e si erano confrontati con l’Italia a loro contemporanea e col suo passato, come Velasquez, o artisti che avevano trascorso la maggior parte del loro tempo in patria, come Rembrandt ad Amsterdam, ma si erano confrontati con l’Italia e il resto dell’Europa…” . con il fine del Barocco: “L’importante è commuovere, stupire, meravigliare (“E’ del poeta il fin la meraviglia”, aveva sentenziato Marino per la poesia); raccontare per persuadere ed accogliere, perché tutto è immagine e comunicazione. Il vero si prolunga nel verosimile, il reale nell’illusione.”: spiega ancora Brunelli.
“Dopo una importante e qualificata serie di approfondimenti specifici sulle diverse declinazioni del Barocco e dei suoi principali interpreti, la mostra forlivese del 2026 intende approntare una visione d’insieme della cultura del Barocco, del dibattito delle idee che lo generarono, dei protagonisti che gli diedero forma, dell’influsso delle committenze che ne favorirono lo sviluppo, della rappresentazione del potere che lo determinò”: conclude il direttore generale delle grandi mostre ai Musei San Domenico di Forlì.


